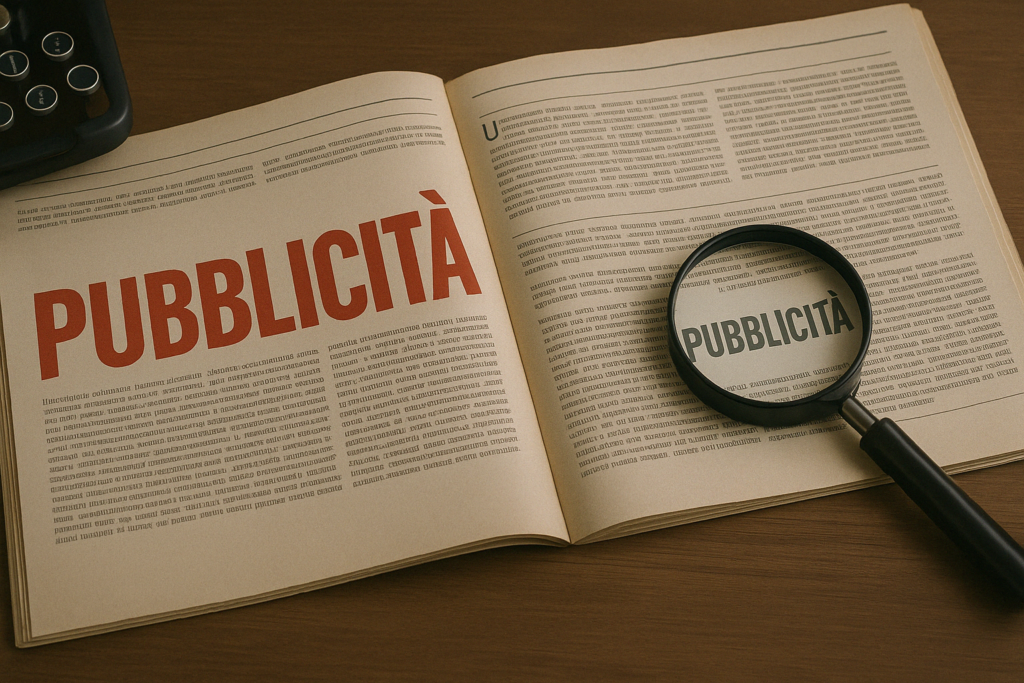
Riflessioni dopo l’inchiesta di Striscia la Notizia su AdnKronos.
C’è un punto, nella storia delle democrazie, in cui la parola notizia deve smettere di essere merce e tornare ad essere bene comune. La recente indagine di Striscia la Notizia – che imputa ad AdnKronos la diffusione, a pagamento, di testi promozionali camuffati da informazione – ci consegna, con la brutalità di un esperimento in diretta, l’immagine di un confine ormai slabbrato. Se per cinquecento euro chiunque può auto‑intervistarsi e ottenere eco su un’agenzia prestigiosa, il patto fiduciario fra lettore e cronista vacilla, e con esso l’ossatura stessa dello spazio pubblico.
Il nodo non è il denaro – le redazioni devono pur sopravvivere in un ecosistema pubblicitario che si ritira come un mare in secca – ma la dicitura; ossia la trasparenza di chi dichiara ciò che è informazione e ciò che è promozione. Communicatio e communio condividono la radice latina: comunicare significa mettere in comune, non confondere. Quando il lettore non distingue più il racconto dal réclame, entra in scena la hybris del mercato, che divora il logos critico e celebra un trionfo privo di vittoria.
AdnKronos, per parte sua, rivendica la separatezza del servizio «Immediapress», gestito – si legge – da «altra e distinta società» all’interno del gruppo. Siamo ai giochi lessicali: la responsabilità “editoriale” viene spostata come una pedina su una scacchiera giuridica, mentre la percezione di chi legge resta, inevitabilmente, unitaria. Quell’intervista – argomenta l’Ordine dei Giornalisti – porta il marchio dell’agenzia, dunque riverbera la sua autorevolezza. Responsabilità non è soltanto un lemma normativo; è un’eco etica che chiama in causa la reputazione, non la sola competenza.
Sotto il velo della prassi – “lo fanno tutti”, “è solo un comunicato” – si nasconde il vero crinale: la metamorfosi del giornalista da custode a correttore di bozze di marchette altrui. È un passaggio culturale che interpella l’intera filiera della produzione simbolica – aziende, uffici stampa, piattaforme, lettori – e che reclama un patto nuovo, fondato sull’esplicitezza. Non basta arroccarsi su disclaimers di poche righe in calce: serve un segno chiaro, visibile, comprensibile al non addetto ai lavori. Il lettore deve poter dire, d’un colpo d’occhio: “questo è sponsor, quest’altro è indagine”.
Il rischio di querela – temuto da molti, evocato da tutti – si esorcizza con la scrupolosa aderenza ai fatti, non con l’autocensura. E i fatti, oggi, dicono che l’assenza di filtri nell’immissione a pagamento di contenuti non verificati è stata documentata pubblicamente. Starà ai Collegi disciplinari accertare le eventuali violazioni; a noi, intellettualmente, spetta l’esercizio del dubbio vigile. Perché una stampa che piega la schiena alla “moneta cattiva” – piccola o grande che sia – non è più quarta estate, ma quinta colonna del marketing.
Che fare, dunque? Rinnovi contrattuali che premino la verifica, modelli di business misti (abbonamenti, membership, eventi) capaci di ridurre la dipendenza dal brand content, ed una didattica permanente della trasparenza: ogni redazione dovrebbe insegnare ai propri lettori a leggere la legenda tipografica del giornale come fosse una carta nautica. Solo così potremo navigare l’arcipelago informativo senza finire su scogli semantici.
Resta una domanda fondativa, cara a chi ancora crede nella funzione maieutica del giornalismo: di che cosa è custode, oggi, la stampa? Se è custode della polis, dovrà difenderne il logos; se, invece, è custode di un mero flusso di click sponsorizzati, allora ammettiamolo senza orpelli e prendiamone atto. Ma chi avrà il coraggio di sottoscrivere, con firma pubblica, quest’ultima dichiarazione?
Il punto, in fondo, non è perseguire moralismi d’occasione. È riconoscere che la democrazia è conversazione continua fra diseguali, resa possibile da un bene fragile: la fiducia. Ogni volta che una testata la baratta per poche centinaia di euro, una parte di noi – lettori, cittadini, persino inserzionisti onesti – perde qualcosa di non monetizzabile. Eppure, basterebbe una linea di demarcazione, netta, limpida: “Questo è pubblicità. Questo, invece, è verità in costruzione.” Chiediamo troppo?

Lascia un commento